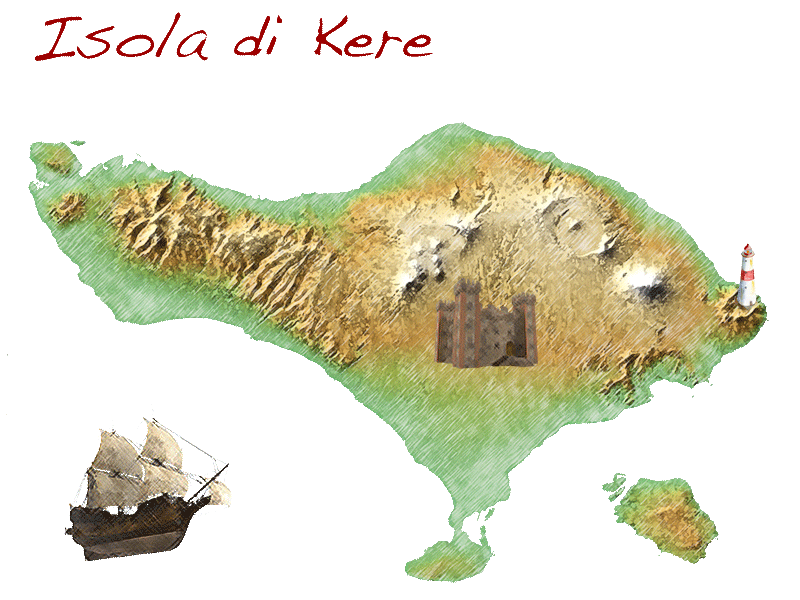
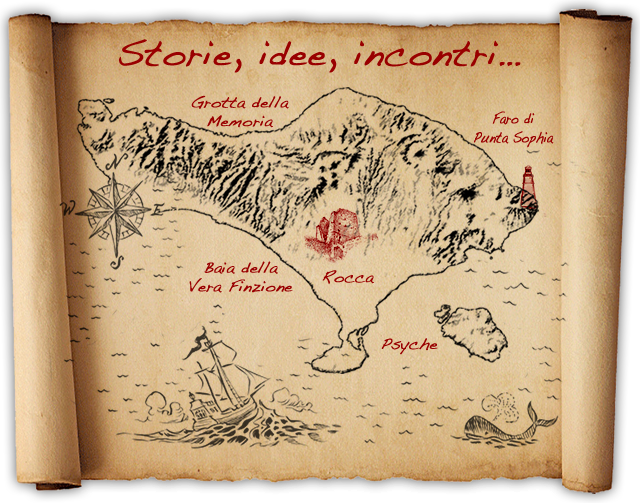
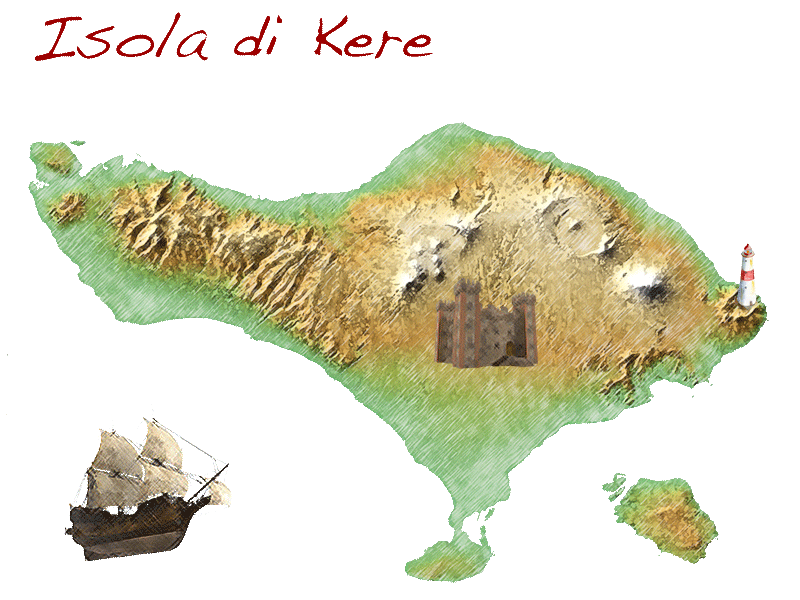
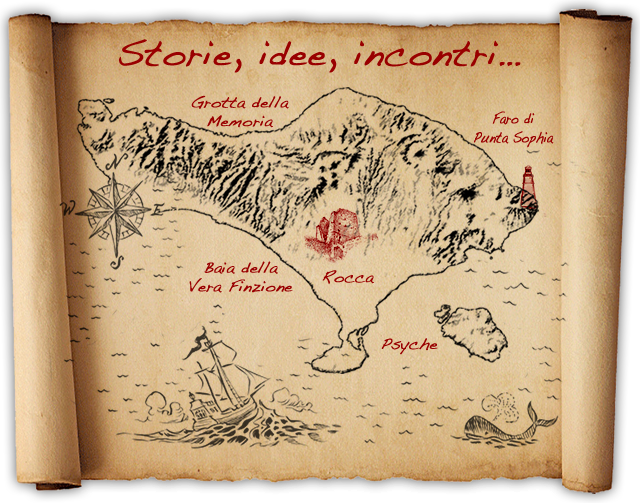
15-04-2014
Perché scrivere? Perché leggere? A che servono le storie?
La risposta a queste domande sembra superflua sia per chi già ama le storie, sia per la grande maggioranza che si tiene a debita distanza da ogni forma di parola scritta, per mancanza di interesse, di tempo, di consuetudine.
Eppure io credo che la questione del "a che servono le storie?" sia assolutamente vitale, letteralmente una questione di vita o di morte, per l’anima come per il corpo.
Gao Xinjian, ancora stordito per l'inaspettato premio Nobel, ha dichiarato a France Press:
“ Questo premio è un segno particolarmente importante giacché io non scrivo per il mercato, per guadagnare soldi o per fare propaganda: fin da giovane ho sempre avuto la mania di scrivere, senza mai fermarmi, e ciò per via delle sofferenze del mio paese. Scrivere per me è sopravvivere. Anche durante il periodo più duro in Cina, ho continuato a scrivere di nascosto, sebbene non pensassi di poter pubblicare un giorno. Da allora ho imparato a non aspettarmi nulla dalla vita” … ”Scrivere per me è il solo modo per restare vivo.”
Le parole di uno scrittore, di un dissidente, di uno nato con il dono delle storie valgono anche per l’uomo comune? Io credo di sì, perché l’esperienza della sofferenza è universale (quella della gioia meno) e condividerla, leggendo o scrivendo o narrando, guarisce l’anima, dà un senso.
Ne trovo conferma e conforto nella testimonianza di Abdellah Ziou Ziou, uno psichiatra marocchino intervistato da Piero Coppo ad Essaouira.
Ziou, che nel 76 aveva partecipato all’incontro di Trieste organizzato da Psichiatria Democratica e dall'equipe di Basaglia, ha lavorato nell'Ospedale di Ber Rechid, il più grande del Marocco, con duemila degenti, di cui 1800 cronici, “ in una piccola città in cui l'Ospedale era la sola fabbrica che dava lavoro alla gente, fabbrica per fabbricare follia, e con l’equipe di medici che già c’era e il personale curante abbiamo fatto un progetto per umanizzare l’Ospedale. Ho contattato alcuni pittori, cineasti, poeti, scrittori: dei creativi, perché ero convinto che, per il fatto di essere dei creativi, avessero una certa disponibilità di ascolto della sofferenza…”
Questo è vero, ed è stato ampiamente dimostrato anche dagli studi sulla personalità creativa: più conflitti e più capacità di avere accesso ai livelli profondi, al processo primario, all’ascolto insomma, di set stesso e dell'altro. Ma vi è una testimonianza decisiva e sconvolgente in un'altra esperienza del dottor Ziou: “ da sette anni animo delle sessioni di psicoterapia di gruppo per i sopravvissuti di Tezmamat e kal Assan Guna, luoghi dove le vittime di tortura hanno passato venti, quindici anni di detenzione segreta; e questo lavoro con le vittime della tortura mi ha permesso di vedere che l’immaginario è un mezzo importante di resistenza. Per esempio a Tazmat c’erano due padiglioni di trenta persone: in uno ci sono stati ventotto decessi e nell’altro solo tre o quattro. Nel padiglione dove ci sono stati meno morti avevano adottato un processo di ciò che chiamo resistenza attraverso l’immaginario:recitavano brani di teatro, facevano pranzi di cuscus il venerdì nel loro immaginario: uno usciva e andava al mercato, l’altro tagliava i legumi, l’altro preparava la semola e poi mangiavano, c’era tra loro un narratore straordinario che raccontava le storie de Le mille e una notte, e tutte queste attività attraverso l’immaginario hanno permesso loro di resistere in quel momento così oscuro e difficile della loro vita.”
Sherazade stavolta era un detenuto torturato, che salvava la vita a se stesso e ai suoi compagni con le sue storie.
Io ho condotto per due anni un corso di scrittura creativa nel carcere di Arezzo, una vera esperienza sub e transculturale: il gruppo era omogeneo non solo per la sua condizione, ma anche per la bassa scolarizzazione: c’ era anche un analfabeta, che amava ascoltare le storie degli altri e dettare le sue all’unico in grado di capire e tradurre il suo dialetto molfettano.
Era certamente transculturale, con la presenza di almeno sei o sette nazionalità e un numero maggiore di etnie. Dell’esperienza ho scritto altrove. Al momento dovrebbe riprendere, quando i tempi burocratici del carcere lo permetteranno. Il successo con i detenuti può essere dovuto a tanti motivi, il più ovvio dei quali è che ogni attività proposta rompe comunque la monotonia del carcere. Ma ciò che mi ha davvero colpito è che un detenuto trasferito in un altro carcere mi ha scritto per chiedermi di continuare gli esercizi di scrittura, e si è unito a lui un altro ragazzo con cui non ho avuto mai contatto: ogni quindici giorni propongo loro un tema, con una piccola storia che lo accompagna. E poi aspetto le loro storie, con l’ansia felice del lettore che si lascia portare via.
Andrea Bocconi